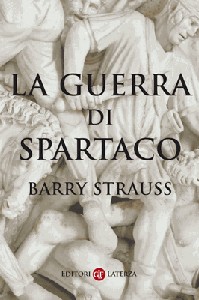|
Un brano del libro tratto da
laterza.it
Spartaco era un gladiatore peso massimo, del tipo chiamato murmillo, «mirmillone». Uomo «forte di animo e di corpo», come dicono le fonti, aveva circa trent’anni. I mirmilloni erano uomini imponenti che nell’arena indossavano 15-20 chili di armi e armatura. Combattevano scalzi e a petto nudo, rendendo così visibili al meglio i tatuaggi con cui i Traci come Spartaco si decoravano il corpo. Ogni mirmillone indossava un elmo di bronzo, un perizoma munito di cintura e varie protezioni per le braccia e le caviglie. Portavano un grande scudo oblungo (scutum) e brandivano una spada dalla lama larga e dritta, lunga circa cinquanta centimetri: il gladius, la classica arma dei gladiatori nonché arma di ordinanza di un legionario romano.
Anche se non sappiamo nulla della carriera di Spartaco nell’arena, lo possiamo immaginare impegnato in un combattimento pomeridiano. Essendo maniaci di questi giochi, i Romani hanno lasciato un’enorme quantità di testimonianze al riguardo, e le ricostruzioni storiche recenti arricchiscono il quadro. Sappiamo per esempio che Spartaco combatteva contro un solo uomo alla volta, nonostante l’immagine hollywoodiana dei combattimenti di massa. I veri gladiatori combattevano in coppie, abbinati con cura in modo che lo scontro fosse appassionante – e la loro vita breve.
Un mirmillone come Spartaco non combatteva mai contro un altro mirmillone; di solito era accoppiato con un thraex. Questa parola significa «trace», ma nell’arena Spartaco non rappresentava il proprio paese, forse perché il padrone aveva paura di eccitare l’orgoglio nazionale del suo schiavo. Anche il trace era un peso massimo, ma doveva essere più veloce e agile. Le sue armi e la sua armatura erano simili a quelle del mirmillone, ma aveva uno scudo più piccolo (parmula) che lo rendeva più leggero e mobile; inoltre aveva una spada ricurva (sica) come quella che i Traci usavano in battaglia.
I combattimenti dei gladiatori di solito cominciavano con un riscaldamento con armi di legno. Poi le «armi affilate» venivano portate e provate per essere sicuri che tagliassero come rasoi. Intanto, Spartaco e il suo avversario si preparavano a morire, ma non salutando il patrono dei giochi: il famoso grido Morituri te salutant, per quanto ne sappiamo, fu un’eccezione rara e posteriore. Invece lo scontro cominciava di solito con un segnale della tibia, uno strumento a fiato simile all’oboe.
Lo scontro si svolgeva con una combinazione di eleganza e brutalità. I gladiatori attaccavano ma raramente incrociavano le spade, perché le loro lame erano troppo corte. Invece colpivano e paravano con gli scudi, spingendo indietro l’avversario, tirandolo avanti o colpendolo con il bordo dello scudo posto orizzontalmente. Il combattimento era scandito più dallo schianto e dal rimbombo degli scudi che dal clangore delle spade.
Un mirmillone robusto, con il suo scutum da 7 chili, poteva colpire più duramente, ma un trace veloce poteva assestare più colpi in successione con la sua parmula da 3 chili. Sapendo quanto danno potesse arrecare la spada curva del trace, Spartaco si proteggeva il fianco, cercando piuttosto di tenere lo scontro su un asse verticale, restando con la spalla e la gamba sinistra costantemente avanti in modo da non concedere aperture all’avversario pur continuando a tenerlo impegnato. Reggeva lo scudo vicino al corpo per impedire al trace di colpirlo con la parmula e destabilizzarlo; di tanto in tanto, lo menava in avanti con un affondo improvviso e potente per far perdere l’equilibrio all’avversario.
Da parte sua il trace, non avendo accesso al fianco di Spartaco, poteva piegarsi e cercare di colpire la sua gamba non protetta. Poteva persino tentare la mossa più difficile: saltare in alto, affondare con forza il braccio destro sopra lo scudo di Spartaco e colpirlo con la sua sica ricurva; ma se queste manovre assassine avessero fallito, avrebbero concesso a Spartaco un’apertura improvvisa. Per Spartaco una mossa astuta sarebbe stata una finta per invitare il trace a portare un affondo, che invece lo avrebbe trovato pronto a parare e assestare una contromossa mortale.
Di tanto in tanto, durante un combattimento, un colpo di traverso andava a segno, lasciando il gladiatore sanguinante ma non ferito a morte. Carico di adrenalina, doveva continuare a combattere anche se ammaccato, stanco e sudato, sempre continuando a pensare ai propri piedi e cambiando tattica. Anche se, a quanto pare, molti duelli duravano solo 10-15 minuti, non c’erano limiti di tempo: il combattimento durava finché uno dei due non vinceva. Intanto, ogni combattente doveva estraniarsi dai rumori della folla e degli strumenti d’ottone che accompagnavano lo scontro e concentrarsi unicamente sul combattimento. Doveva anche provare a tenere a mente le regole. Nei duelli gladiatori non tutto era consentito, e un arbitro (summa rudis) con il suo assistente (secunda rudis) faceva osservare il regolamento. Il punto più importante era che un combattente facesse un passo indietro dopo aver ferito l’avversario.
Immaginiamo che Spartaco avesse fatto perdere l’equilibrio al nemico, gli avesse fatto cadere di mano lo scudo e lo avesse colpito al braccio. In questo caso, Spartaco si allontanava dal ferito: finire o meno il trace non dipendeva dal gladiatore o dall’arbitro, ma dall’organizzatore (editor).
L’organizzatore, a sua volta, consultava il pubblico. La decisione su un combattente caduto era il momento della verità. Se alla folla era piaciuto il gladiatore perdente e pensava che avesse combattuto bene, chiedeva a gran voce di lasciarlo vivere, ma se pensava che il perdente meritasse di morire, non avrebbe esitato a gridare: «Uccidilo!». Faceva un gesto con il pollice, ma al contrario di quel che pensiamo oggi: il pollice in alto significava morte.
In questo caso, ci si aspettava che il perdente si mettesse in ginocchio (se le ferite lo permettevano) mentre il vincitore assestava il colpo di grazia. Nel momento in cui il perdente «riceveva il ferro», come si diceva allora, la folla gridava: «Lo prende!». Poi il corpo veniva portato via su una barella all’obitorio, dove gli veniva tagliata la gola come precauzione contro gli incontri truccati. Seguiva la sepoltura.
Intanto Spartaco si arrampicava sulla piattaforma dei vincitori per ricevere il premio: una somma di denaro e un ramo di palma. Sebbene schiavo, era autorizzato a tenersi i soldi. Dopo essere sceso dal podio, agitava il ramo di palma percorrendo in tondo l’arena in un giro d’onore, ricevendo l’approvazione della folla.
Come scuola di rivoluzione, non era molto plausibile. Ma furono combattimenti come questi a temprare il sangue degli uomini che avrebbero dato vita alla rivolta servile più selvaggia del mondo antico.
|